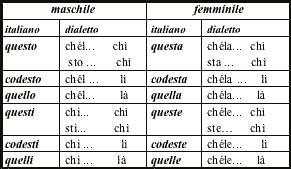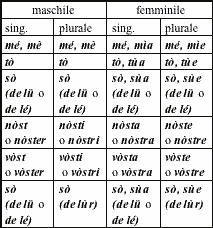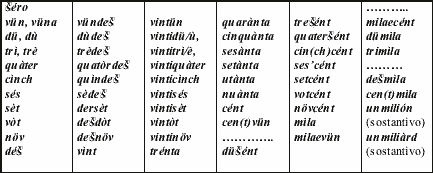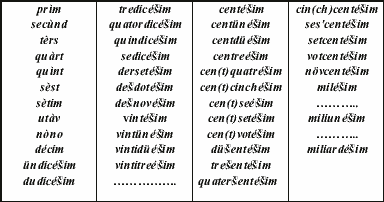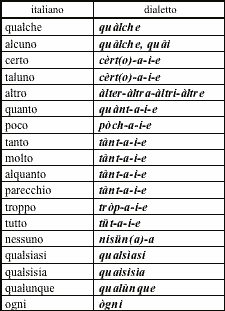|
|
|
|
|
|
AGGETTIVO QUALIFICATIVO
Come il sostantivo a cui si riferisce, può essere maschile o femminile, singolare o plurale.
Modifica pertanto la desinenza secondo il genere e il numero.
Di norma l’aggettivo qualificativo segue il sostantivo.
Gli aggettivi delle qualità e delle grandezze elementari lo possono precedere, es.:«bèl/brüt» «bón/gràm» «bràv/catìv» «grànd/pìcul» «pòch/tànt» «sciùr/pòr» (puarèt segue sempre il sostantivo) «cèrt/tàl» (nel senso di qualcosa di indefinito, come un cèrt valùr; una tal dòna).
I gradi dell’aggettivo
|
Comparativo di uguaglianza
|
In italiano si forma facendo precedere all’aggettivo le particelle correlative <così> e <tanto>, facendole seguire da <come>, <quanto> e simili.
Nel dialetto lodigiano si forma facendo seguire all’aggettivo le particelle correlative «cùme», «tàme» e «’me».
|
Comparativo di maggioranza
|
Si forma facendo precedere l’aggettivo da «püsé» e facendolo seguire dalla preposizione «de» (es.: mì son püsé vég de tì), oppure da «che», soprattutto quando i due termini di paragone sono entrambi aggettivi (es.: l’é püsé scémo che bèl).
Quando i due termini di paragone sono sostantivi, o verbi, il secondo termine può essere preceduto da «che» o da «che nun» (es.: mé fiöla l’é püsé bràva a cüŝì che nun a fà da mangià; gh’é püsé témp che vìta).
Segue le medesime regole del comparativo di maggioranza, con l’uso di «mén» o «ménu», anziché di «püsé».
Nel dialetto lodigiano dovrebbe essere considerato fuori norma l'utilizzo del suffisso «ìsim» (<issimo>) per la formazione del superlativo assoluto, anche se l'italianizzazione del nostro vernacolo ne ha via via incrementato la frequenza. La regola prevede:
| – |
raddoppio del suffisso «ént» dell’aggettivo, es.: dür dürént (durissimo), ciàr ciarént (chiarissimo), bèl belént (bellissimo), pién pienént (pienissimo).
|
| – |
utilizzo di «tròp» (sottolineato nella pronuncia), equivalente a <molto>, es.: l’è tròp bràu (è bravissimo), l’è tròp bèla (è bellissima).
|
| – |
similitudini e paragoni, es.: bón ‘me ‘l pàn (buonissimo di carattere); san ‘me un còrnu (sanissimo), dür ‘me ‘l mür (durissimo); bèl ‘me ‘l sùl (bellissimo); pién ‘me un öv (pienissimo). |
Si forma premettendo l’articolo al comparativo di maggioranza o di minoranza. All’aggettivo seguono le preposizioni «de» (e preposizioni articolate) e «tra», oppure «che (nun)», es.: la partìda püsé bèla del campiunàd; la squàdra püsé fòrta che(nun) ghe sia; el ménu bràu tra tüti.
AGGETTIVO DETERMINATIVO DIMOSTRATIVO
Anche nel dialetto lodigiano si presentano tre forme di aggettivo dimostrativo, confrontate nella tabella che segue con i corrispondenti <questo><codesto><quello> dell’italiano.
| – |
«chél» «chéla» «chi» «chéle» derivano da «quèl» «quèla» « quèi» «quèle» (con caduta della «u» e cambiamento dell’accento da grave in acuto), che avevano funzione sia di aggettivo sia di pronome, mentre ora hanno solamente funzione di pronome.
|
| – |
le particelle «chì» (<qui>), «lì» (<lì>) e «là» (<là>) esprimono il grado di vicinanza spaziale. Tali particelle possono mancare nei seguenti casi:
|
| – |
quando vengono usati «sto» «sta» «sti» come dimostrativi, che non hanno la funzione precisa di evidenziare il concetto di vicinanza (es.: pòrtum sto lìber, dùnca!; e lùr, sti scémi, i han capìd no).
|
|
quando «chél» «chéla» «chi» «chéle», corrispondenti a <quel> <quello> <quella> <quei> <quelli> <quegli> <quelle>, non hanno la funzione precisa di evidenziare il concetto di lontananza (es.: l’é bèl, chél lìber che i t’han dài?; el gh’éva tànta de chéla fàm…; chéle fàte de le sò amìŝe).
|
Oltre al concetto di vicinanza o lontananza spaziale, le particelle «chì» «lì» «là» indicano il grado di vicinanza o lontananza temporale, es.: in chéla stemàna chì (in questa settimana); a chi témpi là (a quei tempi).
AGGETTIVO DIMOSTRATIVO D’IDENTITA'
AGGETTIVO DIMOSTRATIVO DI QUALITA’
AGGETTIVO POSSESSIVO
Per la necessità di evitare equivoci e per meglio chiarire l’effettivo "possessore", si usa anche far seguire il sostantivo da un elemento di specificazione possessiva con il pronome personale inerente, in quanto «sò» non è declinabile; es.: l’é sò de lü sta a significare che "è proprio suo" "è suo di lui".
Da notare che:
| – |
Le forme di prima, seconda, terza persona singolare e di terza persona plurale sono identiche per maschile e femminile, singolare e plurale (mé, tò, sò).
|
| – |
lL’aggettivo italiano <proprio> non ha corrispondente in dialetto e assume la forma di «sò» nei generi maschili, femminili, singolare e plurale (es.: l’è bón da fà i sò afàri).
|
| – |
In prima e seconda persona plurale, accanto alle forme più genuine «nòst» «nòsta» «nòsti» «nòste» «vòst» «vòsta» «vòsti» «vòste», sono in uso anche le forme «nòster».
|
| – |
«nòstra» «nòstri» «nòstre» «vòster» «vòstra» «vòstri» «vòstre».
|
| – |
L’accento su «mé» della prima persona maschile e femminile, singolare e plurale, è chiuso, distinguendosi da «mè» pronome, che ha accento aperto. |
| – |
Nel genere maschile, in prima persona singolare e plurale, l’aggettivo diventa «mè», con accento aperto, quando segue il sostantivo. |
| – |
Nel genere femminile, in prima, seconda, terza persona singolare e terza persona plurale, in luogo di «mé» «tò» «sò» l’aggettivo diventa «mìa» «mìe» «tùa» «tùe» «sùa» «sùe» quando segue il sostantivo (es.: in vìta mìa; in cà tùa; de tésta sùa).
|
| – |
Come in italiano, gli aggettivi possessivi riferiti a sostantivi di parentela non sono di norma preceduti dall’articolo (es.: sò màma e mé neùda). |
AGGETTIVI NUMERALI
Note:
| – |
i numeri «vün» «dü» «trì » sono declinabili al femminile «vüna» «dù» «trè», anche nei numeri composti.
|
| – |
la «t» finale di «cént» scompare nel dialetto parlato.
|
| – |
il numero «mìla» vale sia per il <mille> sia per il <mila> dell’italiano (es.: mìla lìre).
|
| – |
la «c» iniziale di «cént» diventa «s» dolce in «düŝént», «treŝént» e «quaterŝént».
|
| – |
le «v» iniziali di «vün e «vòt» scompaiono nei numeri composti. |
| – |
il numero «utànta» deriva da un più arcaico «vutànta». |
| – |
nel numero diciassette «déŝ» diventa «der» (dersèt).
|
| – |
«vün» e «vüna» hanno solo valore di numero cardinale e non di articolo indeterminativo come in italiano. |
Note:
| – |
tutti gli ordinali sono declinabili al femminile.
|
| – |
soprattutto da «nòno» a «deŝnovéŝim» si capisce come gli ordinali siano stati molto influenzati dall’italiano, tanto che dopo «décim» è ormai nell’uso l’italiano stesso; la forma più genuina, quasi scomparsa, prevederebbe l’utilizzo dell’aggettivo dimostrativo «quèl» seguito dalla preposizione «di» e dal numero cardinale di riferimento (es.: quèl di vündeŝ, quèl di dersèt, ecc.).
|
In italiano sono <ambo> <ambedue> <entrambi>, che indicano un insieme numerico di persone, animali o cose; in dialetto lodigiano l’aggettivo indeclinabile «àmbo» li comprende tutt’e tre.
I sostantivi collettivi dell’italiano <coppia> <paio> dozzina> trovano corrispondenza in «còpia» «pàra» «dunŝéna »; così pure i multipli di <dieci> (es.: vintìna, trentìna, cinquan- tìna…fino a nuantìna).
Per gli altri sostantivi collettivi si usa la forma «un trì» «un quàter» «un déŝ» «un quìndeŝ» «un deŝdòt», ecc.
Ai moltiplicativi dell’italiano <doppio> e <triplo> corrispondono le forme di seguito evidenziate.
Da <quadruplo> in poi si usa aggiungere al numero cardinale corrispondente le forme «…vòlte tànt» o «…vòlte püsé» (es.: el rénde quàter vòlte tànt de quèl che te réndi tì).
AGGETTIVI INDEFINITI
Sono quelli che indicano una quantità incerta, generica.
|
|
|
|